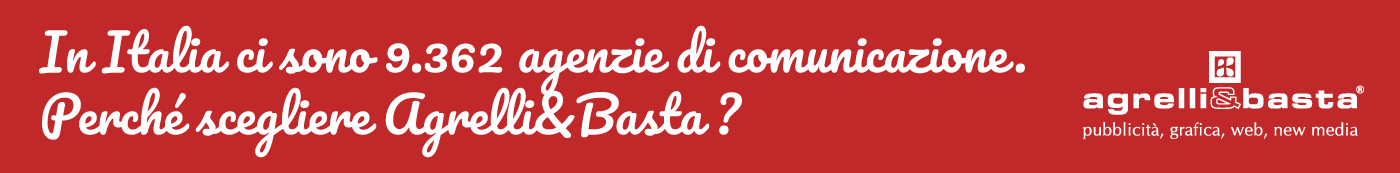Secondo l’Osservatorio Cpi diretto da Carlo Cottarelli e Alessandro Franzetti, vivere a Milano costa fino al 70% in più che in Basilicata. Il dato, ripreso da molti quotidiani, ha riaperto il dibattito sul “costo della vita” e sulla proposta — tornata ciclicamente — di adeguare salari e stipendi alle differenze territoriali. Ma quella cifra, di per sé corretta, dice solo una parte della verità. Perché il “costo della vita” non è solo questione di prezzi. È questione di servizi pubblici, cioè di quanto lo Stato — e gli enti locali — garantiscono gratuitamente o a basso costo ai cittadini. Cottarelli lo sa, e lo dice pure. Ma solo in una nota del rapporto del Cpi, in fondo, in piccolo. Ma continua a chiedere le “gabbie salariali”, più soldi a chi vive e lavora al Nord.
A Milano un affitto è in media più caro che a Napoli o Palermo. Ma a Milano ci sono asili nido pubblici, tempo pieno nelle scuole, trasporti efficienti, assistenza domiciliare per anziani e un sistema sanitario che funziona. Al Sud, molto spesso, no. E allora le famiglie devono supplire da sole: asilo privato, baby-sitter pomeridiana, uso quotidiano dell’auto, badante o infermiere privato, visite sanitarie a pagamento per evitare liste d’attesa infinite.
Il risultato è paradossale: una famiglia del Sud, pur pagando magari beni e affitti più bassi, finisce per spendere di più. E non solo: un contribuente meridionale pagherà due volte per servizi che al Nord sono garantiti. Li paga con le tasse, identiche a quelle di Milano o Reggio Emilia, e li paga di tasca propria, quando deve assicurarsi asilo, sanità, trasporti o mensa scolastica.
Quando si confrontano prezzi e stipendi, inoltre, si confonde spesso il lavoro dell’Istat con la misurazione del “costo della vita”. In realtà, l’Istat non misura quanto costa vivere in un luogo, ma come variano nel tempo i prezzi di un insieme rappresentativo di beni e servizi: il cosiddetto paniere dell’inflazione. Per ciascun prodotto — dal pane alla birra — l’istituto rileva il prezzo di ciò che è effettivamente più consumato in una determinata zona.
Se a Napoli la maggioranza compra una birra da 0,85 euro e a Milano una da 1,50, il prezzo medio riflette le abitudini locali, non la qualità o la “vita più cara”. Al limite, l’Istat misura il livello di potere di spesa dei vari territori. In realtà, l’Istat dice quanto aumentano i prezzi, non quanto costa vivere realmente, né quanto spende una famiglia per sostituire servizi pubblici mancanti. Eppure, indirettamente, quelle differenze di consumo e di potere d’acquisto raccontano la geografia sociale del Paese. Il recente ddl n. 957, approvato dal Senato il 23 settembre 2025 e ora all’esame della Camera, prevede di “favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello” — territoriale e aziendale — per tenere conto delle differenze nel costo della vita. Non introduce differenze automatiche, ma apre la strada a retribuzioni diversificate, almeno nel settore privato. Per il pubblico impiego, invece, non cambia nulla: i salari restano fissati su base nazionale. Il rischio, però, è evidente: se si riconosce che vivere a Milano costa di più e si aumenta il salario solo lì, si cristallizza la disuguaglianza. Perché non si corregge la causa — il diverso livello dei servizi — ma solo l’effetto. Lo scorso anno aveva fatto discutere la proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di differenziare gli stipendi dei docenti per regione. Un’idea respinta dai sindacati, ma rilanciata di recente da alcuni economisti del think tank Tortuga e dal movimento Adesso!, che guardano al modello del London Living Wage: un salario minimo “di città”, calcolato in base al costo della vita reale. Applicato al contesto italiano, quel modello rischia però di accentuare un’ingiustizia di fondo: premiare le aree ricche e penalizzare quelle già povere di servizi e opportunità.
La vera equità non sta nel pagare di più chi vive dove la vita costa cara, ma nel ridurre il costo della vita dove lo Stato è assente. L’uguaglianza non è solo questione di salario, è questione di diritti: scuola, sanità, mobilità, cura. E finché questi resteranno disuguali, nessuna “contrattazione di secondo livello” potrà correggere l’asimmetria di fondo. Perché a Sud non serve un “salario differenziato”: serve un welfare universale.