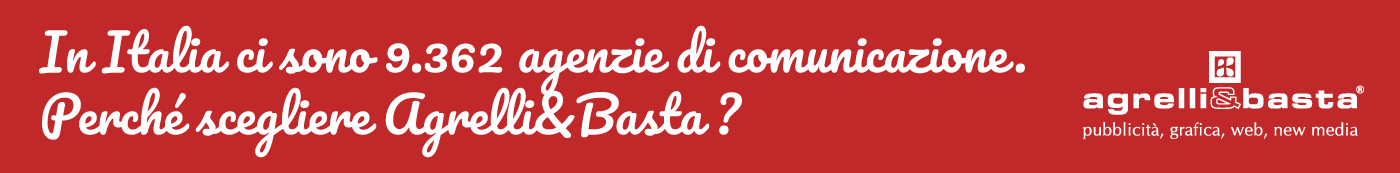Questa domenica la Chiesa chiude l’anno liturgico celebrando Cristo Re dell’universo. Ma fuori, nelle città, le luminarie brillano già da settimane: il Natale corre prima dell’Avvento, come se avessimo paura del buio e della pausa. È l’immagine del nostro tempo: una società che illumina tutto e rischia di non vedere più nulla. Viviamo in un tempo scisso.
Da un lato il calendario religioso, che invita al bilancio; dall’altro quello civile, che spinge alla corsa, alle offerte più convenienti, all’idea che un desiderio abbia valore solo se trasformato in acquisto. Due mappe della stessa vita che raramente si incontrano. Questa distanza racconta una verità scomoda: abbiamo smarrito l’essenziale. Riempire il tempo è diventato più facile che abitarlo; correre più semplice che sostare. Come se temessimo ciò che potremmo trovare nel silenzio: la fragilità, il limite, la domanda che non vogliamo più nominare.
La solennità di oggi, che riguarda anche chi non crede, perché parla di potere e responsabilità, ci offre una domanda civile: come misuriamo il valore di una vita? Se contano il successo, l’immagine, l’abilità di emergere, il risultato è un mondo più fragile e più solo. Se conta la responsabilità, allora ogni gesto diventa parte della costruzione comune. Oggi il linguaggio pubblico si è impoverito, e con esso la nostra capacità di prenderci cura della casa comune. La complessità diventa un fastidio, la sofferenza un numero, i conflitti slogan. Eppure la tenuta di una società si vede proprio nel modo in cui nomina il dolore e non si abitua alla sua presenza. Intanto accendiamo le piazze, mentre altrove le luci non si accendono più: città oscurate dalle bombe, famiglie cancellate, vite interrotte nel silenzio. Parlare di “giudizio” non è predicare: è leggere la realtà. Le società non cedono per mancanza della sola fede, ma per mancanza di senso condiviso. E oggi il senso è soffocato dal rumore, dall’urgenza di apparire, dalla distrazione che ci attraversa. Da qui nasce la zona grigia: il luogo in cui tutto accade senza riguardarci. L’indifferenza non è cattiveria: è stanchezza che diventa normalità. Ma una comunità si spezza quando smette di guardare ciò che fa male. Il giudizio, quello vero, umano, civile, è una domanda semplice: che cosa resta quando si spengono le vetrine? Resta lo sguardo dei fragili. Resta la qualità dei rapporti che abbiamo costruito. Resta la nostra capacità di accorgerci. Lo diceva un vecchio psicoanalista a inizio Novecento: “Lo sciocco cerca la felicità lontano, il saggio la fa crescere ai suoi piedi”. Forse è questo il giudizio che ci attende: non quanto siamo stati fortunati, ma quanto siamo stati umani. E quanto avremmo potuto amare, e non abbiamo fatto. Camus riteneva che l’unico modo per affrontare un mondo senza libertà è diventare così liberi da far esistere la libertà. È un invito a non vivere in superficie, a resistere al cinismo, a scegliere la presenza. Forse il giudizio è tutto qui: quanto siamo rimasti capaci di vedere l’altro? Non l’altro ideale: l’altro reale, quello stanco, ferito, diverso. E allora il giudizio non assomiglierà a un tribunale, ma a uno specchio. Non avrà il tono delle sentenze, ma quello di una luce che cresce piano, come un’alba che non chiede permesso. Ci chiederà: “Che cosa hai illuminato nel tempo che ti è stato dato?”. Forse vedremo la nostra vita come una mappa notturna: poche luci nitide, molte fioche, alcune spente troppo presto. E accanto, le omissioni: la mano non tesa, la parola mancata, lo sguardo evitato. Scopriremo che la vera oscurità non è mai stata fuori, ma nelle cose che non abbiamo voluto vedere. Il giudizio abita i margini: nel bambino davanti a una vetrina di giocattoli che non potrà mai abitare, nel vecchio che attende un autobus che non arriva, nella donna che rientra e non trova nessuno. Lì si misura la direzione di una società. Credenti o no, la domanda è la stessa: chi abbiamo aiutato ad attraversare il buio? Il resto evapora come neve al mattino. Resta solo questo: le ombre condivise e la luce custodita negli altri. Alla fine non saremo ricordati per quanto abbiamo brillato, ma per quanto abbiamo illuminato. E ogni giorno, senza proclamarlo, siamo già noi i primi a pronunciare quel giudizio.