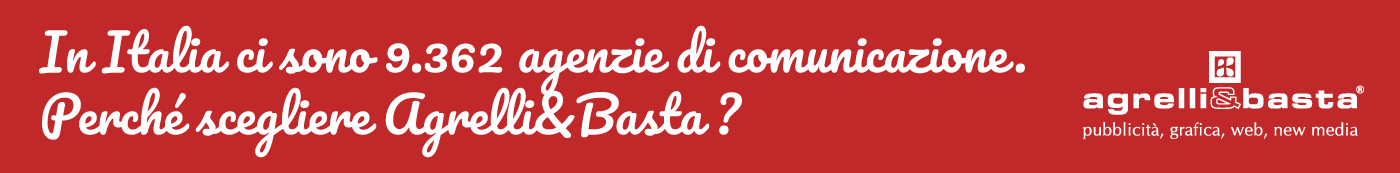A volte veniamo colti da un senso di estraneità all’altro, che va al di là delle differenze che possiamo categorizzare come quelle più visibili.
Siamo sotto lo stesso cielo non solo come presagio di ciò che accadrà, ma lo siamo letteralmente. Eppure, quei pochi passi che dividono un marciapiede dalla strada vengono affrontati diversamente quando ti è possibile muoverti con le tue gambe o quando devi portare con te il peso di una carrozzina.
La città non è più la stessa, le barriere architettoniche ci separano e l’impressione è quella di non vivere più nello stesso luogo, di non prendere gli stessi mezzi, di non poter accedere agli stessi piani. Alcuni di noi si muovono in quello spazio con una velocità allarmante, e spesso non si rendono conto di quante scale percorrono, di quanto in fretta scendono dagli autobus, o di quanto non è mai stato un problema organizzare una cena al ristorante e preoccuparsi solo di prenotare per il numero giusto di persone.
A volte rifletto su quelle stazioni di periferia dove sostano solo regionali, magari con due o tre binari, scale sotterranee necessarie per raggiungere l’uscita senza dover giocare a mosca cieca con i binari, ma senza ascensori. Cosa succede a una persona che è impossibilitata a scendere le scale? C’è un’idea dura a morire, che continua a girare sottotraccia nelle nostre città: che siano le persone a dover essere adatte ai luoghi. Che, se un posto non è accessibile, se è scomodo e ostile, il problema sia di chi non riesce a entrarci. Questo è un limite che col tempo abbiamo faticato a superare, e forse non ci siamo ancora riusciti del tutto a cambiarne la visione. Siamo noi che viviamo i luoghi che abitiamo, che diamo loro la forma che hanno. E sono i luoghi, dunque, a doversi adattare alle persone e ai loro bisogni.
Ci sono battaglie che hanno bisogno di intersezionalità, che non possono funzionare o arrivare agli obiettivi stabiliti senza accogliere con sé altre istanze, e la disabilità è una di queste. La possibilità di fare le stesse cose, come uscire, mangiar fuori, lavorare o entrare in un locale, non dovrebbe essere un gesto di gentilezza. Gli altri non devono arrangiarsi e pianificare ogni gesto come fosse una scalata. Ma la disabilità non è solo una condizione individuale: è il risultato diretto di ambienti che escludono.
In questo panorama desolante, fanno rumore le parole di chi non accetta tutto questo come inevitabile. Come quelle di Angelo Martino, proprietario del ristorante “Al 53”, nel cuore del centro storico. In un post che chiede responsabilità, racconta una verità scomoda: il suo locale non è frequentato da persone con disabilità per caso, ma perché è uno dei pochissimi posti dove possono entrare senza ostacoli nel centro di Napoli.
Martino parla di occhi che valgono più di qualsiasi premio. Occhi di persone che si sentono finalmente considerate, non tollerate ma benvenute. È lì che si misura la serietà di un luogo, non nei titoli, ma nella capacità di non escludere nessuno. E quelle parole che si incontrano portano a una riflessione inevitabile: sentirsi benvenuti e non tollerati, sentire la propria presenza gradita come quella di qualsiasi altro cliente e non sbandierata come gesto di immenso altruismo, come un premio da sfoggiare a se stessi per l’inclusività dimostrata.
Martino denuncia la sua posizione come uno dei pochi locali accessibili non come elogio al proprio lavoro, ma per sottolineare che dovrebbe essere la normalità, o quanto meno, dovremmo provarci tutti un po’ di più invece di rincorrere solo le stelle della qualità. Perché domani, se ci sarà possibile attraversare la strada, dipenderà solo da noi, perché la differenza non sta nelle persone che l’attraversano, ma nel tipo di mondo che avremo costruito.