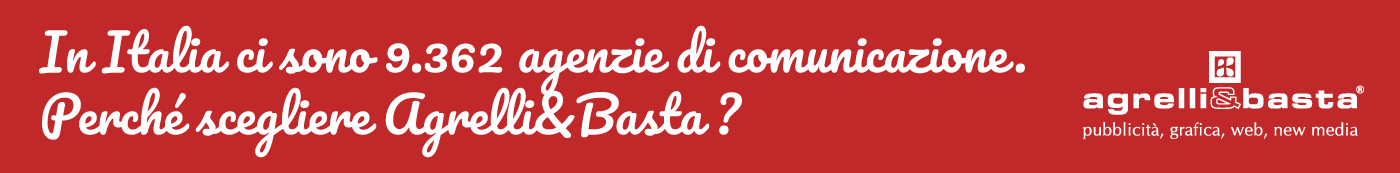Lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta per presunte infiltrazioni mafiose segna un piccolo record. Con esso – e con Casabona, Badolato e Aprilia – il numero delle amministrazioni locali e delle aziende sanitarie che hanno subito questo provvedimento supera quota 400. Una media di circa uno al mese da quando, nell’ormai lontano 1991, la norma fu introdotta. Il governo Meloni ha tenuto il passo. Nei suoi 30 mesi di vita ne ha infatti sciolti 29.
In questi 34 anni, gli scioglimenti hanno perlopiù riguardato piccoli comuni. Non sono però mancati i casi di comuni medi e perfino grandi. A essere colpite sono state amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra, così come quelle più o meno genuinamente “civiche”. Comprensibilmente, la gran parte dei comuni è situata nel Mezzogiorno, ma qualche sporadico caso si registra anche nel Centro-nord.
All’interno di questo quadro, cosa ha di peculiare il caso di Caserta? A giudicare dalle informazioni disponibili e dalle prime prese di posizione, sarei tentato di rispondere “quasi niente”. Anche a Caserta, come spesso accade, lo scioglimento giunge infatti subito dopo un intervento della magistratura che tocca il governo cittadino. Nella pratica, ne è ormai diventato un (improprio) corollario. Anche la reazione dell’amministrazione locale non riserva sorprese. Tranne pochi casi limite, i sindaci gridano regolarmente allo scandalo, denunciano la natura politica del provvedimento, promettono di ricorrere in tribunale. Soprattutto, si fanno alfieri e difensori dell’intera comunità locale.
Il complotto politico esercita sempre un suo fascino. Il campanilismo e il localismo mobilitano potentemente l’opinione pubblica. Le opposte tifoserie politiche non aspettano altro che gettarsi nella mischia. Del resto, siamo un paese in cui, ormai da molti anni, è diventato normale per la politica screditare le sentenze, perfino quelle passate in giudicato. Non stupisce, allora, che un atto che gode di una certa discrezionalità come quello dello scioglimento, sia accolto così da politici e cittadini. Se poi, come nel caso di Caserta (e come mostra l’accesa discussione intorno al recente mancato scioglimento di Bari) il colore politico del Governo nazionale è opposto a quello dell’amministrazione locale, le illazioni e i commenti critici appaiono inevitabili.
In molti casi, l’ “onta” dello scioglimento suscita una generalizzata indignazione nella comunità locale. Questo sentimento, spesso fomentato e cavalcato dagli amministratori locali, non è un fuoco di paglia, ma genera effetti politici e sociali persistenti. La comunità locale si stringe intorno ai suoi rappresentanti feriti, si incaponisce e sembra aderire alla celebre frase attribuita al Presidente Roosevelt a proposito del “nostro figlio di …”.
Infatti, ben 52 sindaci sui 328 che hanno avuto il tempo di ricandidarsi dopo il commissariamento sono stati rieletti (26 come consiglieri e 26 come sindaci). In altre circostanze, come nell’ormai famigerato caso di San Luca, gli elettori si sono invece messi l’anima in pace e hanno smesso di presentare liste alle elezioni. Stretti tra mafia e antimafia, nessuno si sente più di metterci la faccia.
Fin qui, il caso di Caserta sembra dunque seguire un copione collaudato. Se si volesse trovare una sua peculiarità si potrebbe dire che la città campana è il terzo capoluogo di provincia a essere sciolto, dopo Reggio Calabria e Foggia.
La norma, però, tratta tutti più o meno allo stesso modo: la durata del commissariamento è identica; i commissari straordinari sono sempre tre e provengono dalle stesse fila di quelli che gestiscono anche i micro comuni; la normativa e il raggio d’azione dei commissari sono bene o male simili.
La legge del 1991 era nata soprattutto per i piccoli comuni. Malgrado ciò, perfino Roma, dopo l’indagine su Mafia capitale, ha rischiato il commissariamento. Compito arduo, per tre commissari, governare la città eterna.
Nei primi anni ’90 c’era poi un’altra mafia. Una mafia che sparava e intimidiva apertamente. Che, soprattutto nei piccoli centri, spadroneggiava. È ancora questa la natura della minaccia mafiosa? La domanda è evidentemente retorica.
Negli ultimi 35 anni le mafie sono profondamente cambiate. Come accade anche in altri ambiti – quindi nessuno si scandalizzi – le politiche pubbliche contro la mafia sono affette da una certa inerzia. Anche quando ci si rende conto che gli strumenti non funzionano più come prima, rivedere o “smontare” pezzi della legislazione antimafia è infatti difficile e politicamente molto rischioso. L’antimafia è un oggetto rovente per chiunque e perfino gli interventi di buonsenso, nel clima politico attuale, sarebbero certamente strumentalizzati dagli avversari politici. A dispetto di ciò, penso sia giunta l’ora di guardare in faccia la realtà, prendere il coraggio a due mani e intervenire sulla legislazione che si propone di contrastare e recidere i legami tra politici, affaristi e mafiosi che funestano i nostri territori. In ballo non c’è solo la buona amministrazione, ma la tenuta e la popolarità stessa della lotta alle mafie.
L’autore è ordinario di Sociologia dei fenomeni politici all’università di Firenze