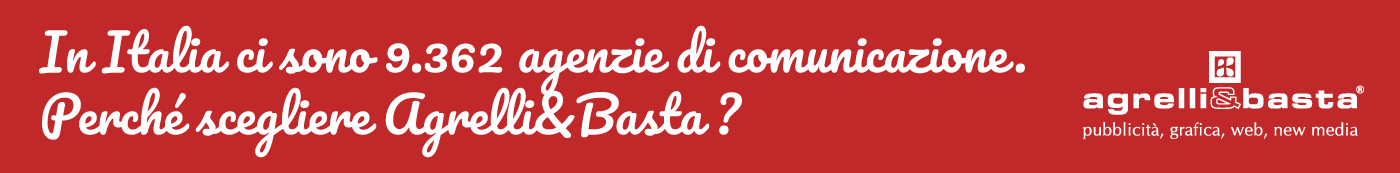Spesso Napoli getta ombra anche dove non è mai stato il sole. Accade anche in giornate di sontuosa e azzurra luce, come queste autunnali, dove l’estate non è morta e l’inverno è di cristallo. In questa luce si sta comunque fermi al semaforo: traffico, come sempre. Un traffico barocco e misterioso, che spesso svanisce d’incanto, di cui invano si cerca la ragione.
Su una delle tante strade in discesa, dove palazzi antichi e chiese se ne stanno inclinati, in discesa a loro volta, come se si sopportassero da secoli, si tenessero a braccetto e potessero scivolare e accatastarsi gli uni sulle altre, come un castello di carta. Che fate tutti per la strada a mezzogiorno? Perché non siete in ufficio, a scuola, al lavoro? Ci sono città orizzontali che paiono deserte al culmine del giorno, come se un incantesimo avesse addormentato tutti, e dove fra le case passa aria, come se si trattasse di denti ordinati e puliti di bambini quieti.
A Napoli, invece, la cieca parabola di molari e canini, di case consunte, di affastellamenti e scivolamenti del tempo, morde: è per questo che si alzano gli occhi a cercare sollievo, è per questo che, in fondo alla discesa, vediamo una collana di palloncini bianchi, ancorata chissà a cosa, spostata dal vento. Sembra una collana di perle, di quelle che usavamo per giocare alle signore, senza fermaglio, che si apriva tirando con entrambe le mani. Le perle finte per la scena.
Per un momento, il pensiero anomalo di un addio al nubilato in pieno giorno attraversa il rumore dei clacson. Invece, il semaforo scatta e noi cadiamo verso l’incrocio e per un attimo passiamo accanto a un carro funebre: dentro la bara è bianca e così sappiamo che la collana di palloncini bianchi è per un bimbo morto. Però il cielo è troppo terso per il funerale di un bambino. Passata la chiesa in discesa – il traffico s’è di colpo sbloccato, era formato dalle auto in doppia fila del funerale – cerco invano le immagini dei genitori accartocciati, dei compagni di scuola che giocano: c’è già il mare in lontananza, il profilo remoto e azzurro di vulcano e costiera che occhieggia profittando di altri palazzi in discesa, che rotolano verso il mare e scoprono il fianco della sirena. E allora risento le parole di Giuseppe Marotta: “Certo si può morire dovunque. La morte, al mio paese, è napoletana: vi abita regolarmente, non viene né dagli abissi né dalle stelle. Ogni uomo a Napoli dorme con sua moglie e con la morte.” Nei racconti de “L’oro di Napoli” al cimitero di Poggioreale un bambino, nero come la pece, mangia un biscotto “inzuppato di lacrime” e guarda una farfalla che, mentre i becchini versano palate di terra nella fossa, viene investita e cade.
“La morte è la più vera e antica cittadina di Napoli” e “i rapporti dei napoletani con lei sono soltanto quelli di una sincera e civile parentela”, scrive Marotta. Intanto, in auto arrivo quasi al lungomare e allora con me corrono le immagini di Vittorio De Sica, la carrozza che porta il bimbo morto, la processione seguita dalla madre, dalla maestra, dai compagni. La morte che sfila quieta lungo il panorama. E, chissà come, chissà perché – sarà una manifestazione, un evento, una coincidenza – lungo ogni strada, mentre avanziamo, di tanto in tanto, un palloncino bianco appare nelle mani dei passanti, un venditore ne tiene un mazzo legato a una spalla, un palloncino sfugge, perla isolata che vaga verso il blu, ostia che sparisce in cielo (ancora Marotta: “Giugno, mi dai Napoli su un piattino come la comunione”). Ogni cosa mi appare infine barocca, memento mori, beffa e sorriso, liquida commedia dell’arte. A quella collana di palloncini che sta al collo della città per un giorno, ornamento all’addio di un bambino, si pensa e si ripensa mentre tutto è ancora, sempre, inesorabilmente così bello.