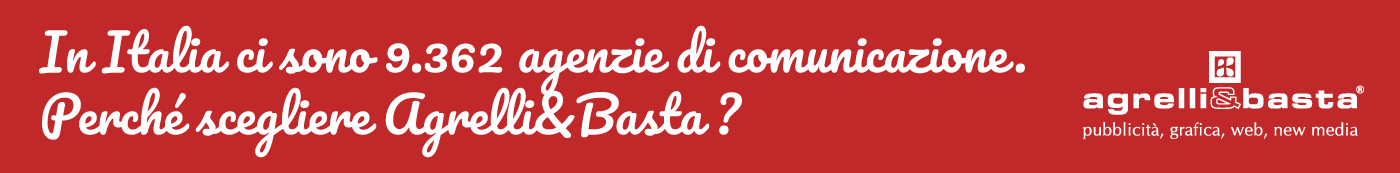Per molto tempo la sicurezza è rimasta un tabù per la sinistra. Impronunciabile e guardata con sospetto. Un tema da trattare con cautela, da tenere fuori dal vocabolario ordinario del campo progressista per evitare equivoci, accuse di cedimento, scorciatoie polemiche. Così, mentre veniva declassata a questione marginale o culturalmente scivolosa, diventava il terreno più semplice da occupare. Oggi il Movimento 5 Stelle sceglie di rientrare su quel terreno senza attenuanti e senza travestimenti.
La linea è ormai esplicita. Giuseppe Conte lo ripete con insistenza: esiste una domanda reale di sicurezza, diffusa, trasversale. Persone che modificano abitudini, evitano luoghi, rinunciano a pezzi di spazio pubblico. Non per suggestione ideologica, ma per esperienza concreta. Ignorare questa domanda non è prudenza, è un errore politico. E affrontarla non significa adottare il linguaggio della destra, ma sottrarre il tema alla sua semplificazione sistematica. C’è poi un ulteriore elemento, spesso rimosso, che rende questa svolta politicamente sensata. La sicurezza è anche una questione di disuguaglianza. L’insicurezza non colpisce tutti allo stesso modo. Chi ha risorse cambia quartiere, orari, mezzi, stili di vita. Chi non le ha, resta esposto. La retorica che minimizza il problema finisce per tutelare i più forti e lasciare soli i più fragili. Rimettere la sicurezza al centro significa riconoscere che la libertà di muoversi, lavorare, abitare lo spazio pubblico non è un lusso, ma una condizione di cittadinanza. In questa cornice si colloca l’iniziativa legislativa del Movimento 5 Stelle sul contrasto ai reati predatori. Un impianto che interviene su borseggi e microcriminalità con strumenti operativi: procedibilità d’ufficio, aggravanti, piani straordinari di prevenzione, strumenti digitali per facilitare le denunce, risorse dedicate. Misure che non cercano l’effetto annuncio né il titolo gridato, ma provano a rimettere ordine in un segmento di realtà che incide direttamente sulla vita quotidiana delle città, sui trasporti, sui quartieri più esposti, sulle fasce sociali meno protette.
Il punto politico non è solo la quantità dei reati, è il rapporto tra cittadini e spazio pubblico. Quando la percezione di insicurezza cresce, lo Stato arretra simbolicamente. E quando arretra, perde autorevolezza prima ancora che controllo. È in quel vuoto che emergono figure irregolari, come Simone Ruzzi, in arte Cicalone. Il suo seguito racconta una frattura per cui quando la risposta pubblica appare insufficiente, si affermano surrogati informali, spesso ambigui, talvolta pericolosi. Non è un’anomalia ma una conseguenza prevedibile.
Il Movimento 5 Stelle non lo trasforma in simbolo, né lo assume come soluzione. Ne riconosce però la funzione di segnale. Cicalone non è il punto di arrivo, è il sintomo. Il messaggio implicito è chiaro: la sicurezza non può essere delegata né all’iniziativa individuale né alla visibilità social. Deve tornare dentro un perimetro pubblico, regolato, verificabile. Di governo. Ed è qui che la scelta del M5s segna una discontinuità reale, anche rispetto a una parte della sinistra che ha preferito ridurre il tema a un riflesso culturale o a un rischio reputazionale.
Non è una svolta indolore. Nel campo progressista emergono resistenze, diffidenze, linee di frattura evidenti. Per anni la sicurezza è stata trattata come un costo politico, non come una responsabilità di governo. Rimetterla al centro significa accettare il conflitto, esporsi alla critica incrociata, rinunciare a una parte di rendita simbolica. Ma proprio questo ne certifica la portata. Il Movimento non cerca una sintesi accomodante ma uno spazio politico autonomo.
E lo fa su un terreno che intreccia consenso, conflitto sociale, percezione diffusa e capacità amministrativa. Un terreno che peserà sempre di più da qui alle prossime elezioni politiche, perché incrocia la vita quotidiana più di qualunque slogan identitario. Se la sicurezza resta un tema bandiera, serve solo a dividere. Se resta un tema rimosso, serve solo a perdere terreno. Il Movimento 5 Stelle sceglie una terza strada, trattarla come un problema concreto da amministrare, non come una scorciatoia identitaria. È una mossa che sposta gli equilibri, perché toglie alla destra l’esclusiva del linguaggio e costringe il campo progressista a uscire dalla propria zona di comfort. Non è un’operazione rassicurante, né indolore. È una scelta che obbliga a misurarsi con responsabilità, risultati, contraddizioni. In un sistema che vive di slogan replicabili, decidere di entrare nel merito è un atto controcorrente. E questo, oggi, è già un fatto politico.