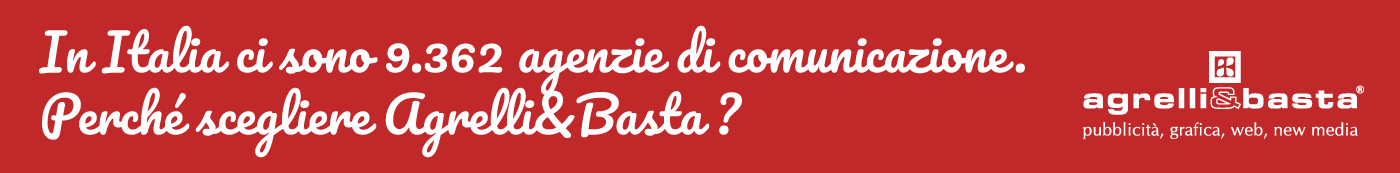Pasolini e il “Laceno d’Oro”: è stato un flash, ma di quelli che illuminano per sempre la vita di una comunità e restano impressi nella sua memoria collettiva. In una lettera del 30 agosto del ’59 Pier Paolo Pasolini comunica all’amatissima madre Susanna l’imminente partenza per Avellino, dove giunge il 5 settembre, accolto con grandi onori al Circolo Sociale.
L’indomani è a Bagnoli Irpino, sull’altopiano del Laceno, che da quell’anno ospiterà uno dei festival cinematografici più originali d’Italia, l’unico al mondo dedicato al Neorealismo, giunto quest’anno alla 50° edizione. Accolto con interesse e simpatia, Pasolini firma decine di copie del suo recente successo editoriale “Una vita violenta” e ritira il primo Premio “Laceno d’Oro” alla regia per conto di Michelangelo Antonioni, vincitore con “Il grido”. Lo scrittore friulano è rimasto colpito da un’accorata lettera inviatagli l’anno precedente da due giovani intellettuali del Sud, Camillo Marino e Giacomo d’Onofrio, e decide di aiutarli a realizzare il loro sogno: dar vita nella provincia di Avellino (all’epoca la più povera d’Italia) ad un premio cinematografico e ad una rivista specializzata. L’intervento di Pasolini è decisivo: nel ’58 nasce la rivista “Cinemasud” (su cui lo scrittore-regista pubblicherà poesie, saggi e soggetti cinematografici, oggi antologizzati nel volume di Simona Dolfi Pasolini e “CinemaSud”) e nel ’59 il “Laceno d’Oro”. Il 31 luglio del ’60 Pasolini è di nuovo sul Laceno, per la seconda edizione del Premio, seduto accanto all’attrice Laura Betti, sua amica e musa ispiratrice, nella prima fila di una platea di circa ventimila persone.
Fra gli ospiti c’è Domenico Modugno, diventato una star internazionale con la canzone “Volare”, che per Pasolini comporrà la stupenda colonna sonora di “Che cosa sono le nuvole”. Pasolini chiede a Marino di accompagnarlo al santuario della Madonna di Montevergine, dove registra dalla viva voce di alcuni giovani del posto la versione originale della Canzone di Zeza, un canto popolare del Carnevale, che costituirà la sigla di testa del suo Decameron. Con Pasolini il “Laceno d’Oro” nasce all’insegna del binomio cinema-letteratura, consolidato dal ‘66 con la presidenza di Domenico Rea, che del Festival fu un sostenitore convinto: “Bisogna dire subito – scrive nel ’68 in un’accorata lettera al presidente della Provincia di Avellino – che esso rimane il premio più sganciato, spontaneo, ricco di improvvisazioni e di illuminazioni che nel campo della cinematografia vi sia in Italia”. La presidenza quinquennale di Rea coincide con l’ “età d’oro” del Festival irpino, in una felice simbiosi di “dolce vita” di provincia e di fermenti culturali del ‘68. Toccò allo scrittore napoletano, nel ’66, consegnare il primo premio alla grande attrice svedese Ingrid Thulin, l’anno successivo ai fratelli Paolo e Vittorio Taviani per I sovversivi, nel ’69 a Ettore Scola (per Il commissario Pepe), nel ’70 al regista di Drop out Tinto Brass e ai protagonisti Franco Nero e Gigi Proietti. Furono gli anni del “disgelo” verso il cinema dell’Est europeo, dei dibattiti tra autori e pubblico dopo le proiezioni, della “scoperta” di tanti attori e registi: un festival giovane, coraggioso e conosciuto in tutto il mondo fu quello che Rea riconsegnò nel ’70 alla coppia Marino-d’Onofrio e al suo prestigioso successore: Cesare Zavattini. L’ultima edizione si svolge nel 1988.
Intanto, il 1 novembre del 1979, nel ventennale del “Laceno d’Oro” e a quattro anni dal barbaro assassinio sul litorale di Ostia, un gruppo di cineasti di tutto il mondo, su invito di Marino e d’Onofrio, aveva posto una lapide in memoria di Pier Paolo Pasolini, che con la sua presenza in Irpinia – come ricorda in questi giorni la mostra promossa dalla Biblioteca dell’Università di Salerno con l’Archivio di “CinemaSud” – aveva dato l’impulso decisivo alla realizzazione di una incredibile e meravigliosa utopia.