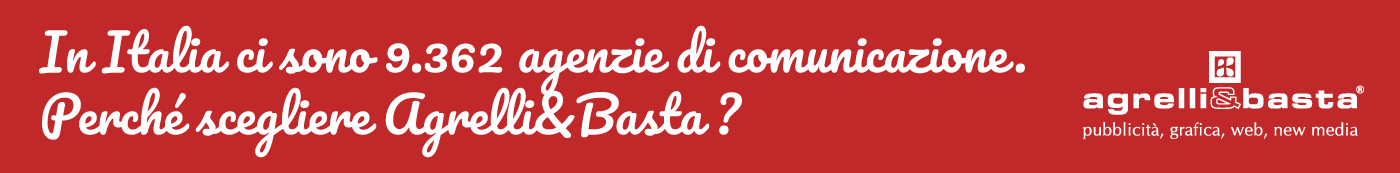Il fatto, innanzitutto. Il gruppo giovanile leghista di Roma ha diffuso sui social un video breve, costruito secondo i codici della comunicazione virale. Il titolo recita: “Quando un radical-chic di sinistra vuole farti la morale”. A corredo, una clip tratta da M, la serie ispirata ai libri di Antonio Scurati, in cui Luca Marinelli, nei panni di Benito Mussolini, descrive Giacomo Matteotti con queste parole: «Il socialista impellicciato, famiglia ricchissima. Suo padre era un latifondista, dicono che prestasse denaro a usura ai suoi contadini.
E lui cosa fa? Si mette dalla parte dei contadini, della povera gente. Ma vada a lavorare la terra, invece che rompermi i coglioni a me». Il video ha avuto un’ampia diffusione in termini di visualizzazioni. Ma il punto non è il successo algoritmico. Quella frase è rappresentativa della vulgata denigratoria messa in atto dagli ambienti fascisti fino al giorno del rapimento di Matteotti. Rapimento che si concluse con l’assassinio del deputato socialista, sequestrato dopo il suo intervento alla Camera in cui aveva denunciato il clima di violenza e illegalità che aveva segnato le elezioni del 1924, chiedendone l’annullamento. Matteotti proveniva effettivamente da una famiglia benestante. Proprio per questo fu oggetto, già allora, di una campagna di delegittimazione sistematica. Per i suoi denigratori era il “socialista milionario”, il traditore della propria classe.
Eppure scelse consapevolmente di dedicare la propria attività politica alla difesa dei contadini e degli operai. La sua colpa non fu l’origine sociale, ma la rottura dell’ordine. L’aver dimostrato che la rappresentanza politica può nascere anche contro il proprio ambiente di provenienza. È a partire da qui che l’episodio va letto politicamente. Ripescare una frase di Mussolini, estrarla dal suo contesto storico e inserirla in una polemica contemporanea contro chi “fa la morale” non è una leggerezza comunicativa. È un’operazione di riscrittura simbolica. Non si dice che l’assassinio fu giusto, ma si suggerisce che chi denuncia, chi disturba, chi mette in discussione il potere costituito, sia una figura fastidiosa, ipocrita, caricaturale.
È un linguaggio che lavora per allusione, non per affermazione. Ed è proprio per questo che è efficace ai tempi dei social. La storia viene ridotta a repertorio. Il fascismo non viene discusso né criticato, viene normalizzato. Il delitto che segna uno spartiacque nella vicenda istituzionale italiana, con il passaggio dalla violenza politica diffusa al regime, viene trasformato in materiale di intrattenimento. Il carnefice diventa personaggio e la vittima stereotipo. Non è nostalgia dichiarata. Non è neppure apologia esplicita. È qualcosa di più insidioso. Un riconoscimento tacito della violenza politica, travestito da ironia e da linguaggio generazionale. La memoria non viene negata, viene svuotata. Ma non è solo questo. È il rapporto tra politica e linguaggio pubblico che viene tirato in ballo. Legittimare l’allusione violenta significa abbassare la soglia democratica e preparare il terreno all’irrisione sistematica di ogni controllo e di ogni parola scomoda. Un segnale da non sottovalutare.
Per questo il punto politico, oggi, è la responsabilità di chi tenta di far rientrare quel lessico nel circuito dell’accettabile. Quando un movimento politico giovanile usa una frase del dittatore fascista come battuta contro i presunti moralisti, compie un’operazione di diseducazione democratica. Perché suggerisce che l’obiezione è fastidio e che il dissenso è merce derisoria. È la stessa logica che allora cercò di trasformare il parlamentare socialista in una macchietta per renderne plausibile la rimozione. C’è poi un nodo culturale non eludibile. La democrazia vive di alcune regole unanimemente accettate. Una di queste è che l’assassinio politico non si maneggia come linguaggio di parte. Mai. Spezzare questa regola significa lavorare contro l’idea stessa di limite condiviso, che è il cuore della civiltà costituzionale. In una Repubblica che nasce anche dal sangue di Giacomo Matteotti, questo non è un dettaglio comunicativo. È una chiara scelta culturale e politica. E come tutte le scelte di questo tipo, va chiamata con il suo nome e per questo condannata. Senza attenuanti, né indulgenza.