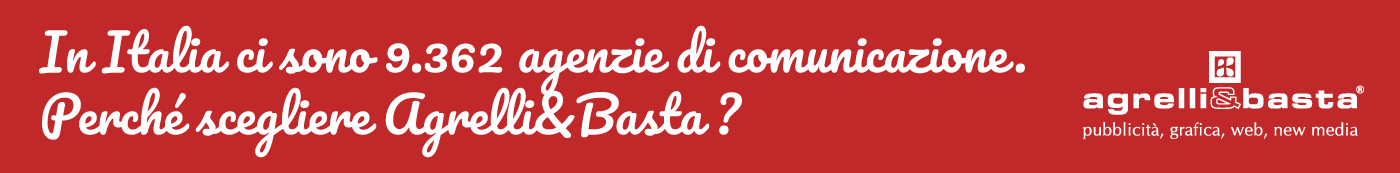In Puglia, a giudicare dai numeri, non sembrerebbe esserci partita. Eppure, è proprio quando il risultato appare scontato che la politica rivela le sue verità più profonde. Antonio Decaro viaggia verso una vittoria ampia, ma il dato non riguarda solo lui, racconta di un modello e della maturazione di un sistema. La Puglia ha costruito nel tempo una filiera di governo coerente, in cui la continuità amministrativa è diventata risorsa, non zavorra. È l’esito di una lunga sedimentazione di pratiche e linguaggi che hanno fatto della politica una espressione di responsabilità più che di appartenenza.
Qui il centrosinistra non si è limitato a sopravvivere, ha imparato a trasformarsi. Dopo la stagione ideologica di Vendola, la Puglia ha imboccato la via di un riformismo pragmatico, capace di unire l’efficienza tecnica alla sensibilità sociale. Un modello municipale e diffuso, dove la leadership non si impone dall’alto ma nasce dalle esperienze amministrative dei sindaci, dai territori, dalle reti civiche che hanno saputo connettere istituzioni e comunità. Il suo può essere un esempio. Quello di una regione che ha saputo trasformare il consenso in metodo, la politica in amministrazione, la continuità in valore. In Puglia, il centrosinistra è diventato una macchina territoriale efficiente, un sistema di relazioni tra istituzioni, comuni e società civile che produce stabilità, visione e fiducia.
Il segreto sta nella trasformazione di un approccio localistico in cultura di governo. Passato il tempo del carisma e delle contrapposizioni ideologiche, la Puglia ha scelto la concretezza. Infrastrutture, fondi europei, sostenibilità, rigenerazione urbana. Ha fatto della gestione la propria grammatica politica, del radicamento la propria ideologia. È un “civismo istituzionale” che non rinnega la sinistra, ma la declina nella forma dell’agire amministrativo.
Il confronto con la Campania è inevitabile. E illuminante. Qui il campo politico è molto più frastagliato, attraversato da correnti e da identità in cerca di sintesi. Se la Puglia offre l’immagine di una coalizione coesa, la Campania somiglia più a un mosaico di esperienze e di leadership territoriali, spesso autonome, talvolta divergenti. È la differenza tra un sistema che si riconosce in un progetto e uno che ancora si misura con la propria frammentazione.
In Campania, il centrosinistra ha costruito la sua forza su un potere regionale essenzialmente accentrato, capace di garantire stabilità ma anche di comprimere le dinamiche interne. Ora quel modello mostra la fatica della durata. Le nuove generazioni amministrative stentano a emergere, i territori chiedono rappresentanza e il civismo, che altrove è diventato struttura, qui rimane spesso movimento episodico, espressione di protesta o di identità locale.
Il risultato è che la Puglia è riuscita a dare forma politica all’amministrazione, mentre la Campania resta prigioniera della dialettica tra potere e pluralità. In Puglia il consenso nasce dall’efficacia, in Campania dall’identificazione. La prima ha normalizzato la politica, la seconda la mantiene in uno stato permanente di tensione, di discussione, di teatro pubblico.
Ed è proprio questa tensione a rendere la Campania un laboratorio più instabile, ma forse più vitale. Laddove la Puglia esprime una sinistra governante, disciplinata e tecnicamente solida, la Campania conserva la dimensione conflittuale della politica meridionale. Più caotica, più umorale, ma anche più capace di rigenerarsi attraverso lo scontro.
C’è poi una distinzione culturale. In Puglia la politica si è fatta mestiere collettivo. Un lavoro di squadra che premia la mediazione, la competenza, la continuità. In Campania, invece, la tradizione resta segnata da una dimensione più personalistica, più narrativa, più legata alla figura del leader di turno. È una regione dove la politica è ancora racconto e rappresentazione, più che struttura e processo.
Ma questo non è necessariamente un limite. Anzi, in Campania sopravvive una vitalità che altrove si è spenta. E che si manifesta attraverso la capacità di generare conflitto, di produrre dibattito, di rimettere continuamente in discussione gli assetti. Laddove la Puglia offre la stabilità, la Campania mantiene l’energia del cambiamento, anche se spesso disordinato. È la dialettica di due Sud allo specchio, che rappresentano due anime dell’Italia. Due Sud e due modernità diverse. Quella pugliese, fondata sulla continuità e quella campana, ancora alla ricerca di una nuova formula di governo e di una leadership diffusa. Il futuro del centrosinistra meridionale passa dall’incontro tra questi due modelli. La concretezza pugliese e la vitalità campana. Senza la prima non si governa, senza la seconda non si cambia.