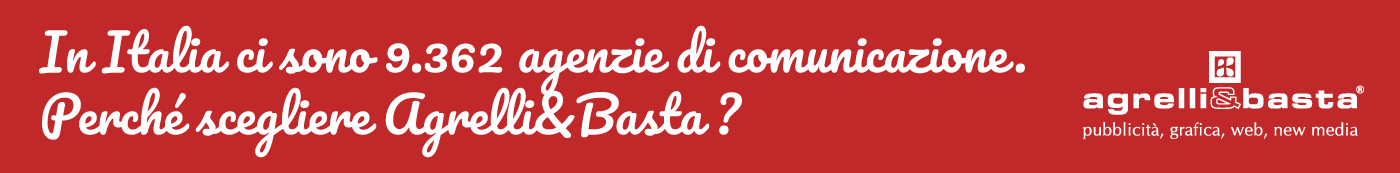Sarebbe stata l’ultima edizione di Galassia Gutenberg quella del 2007: scrittrici e scrittori napoletani erano chiamati a leggere testi propri sul classico tema della sirena. C’era anche Fabrizia Ramondino, mancava un anno alla sua morte, che sarebbe accaduta in mare, come per le sirene spiaggiate sulle coste campane. L’età, i dispiaceri, le dipendenze non impedirono alla sua lettura d’essere straordinaria. Avevano, e hanno, un peso le sue parole, quelle di un classico, che era molto chiaro anche mentre lei era ancora qui, su questo incerto confine fra mare e terra dove abitiamo.
Non passa anno ch’io non legga in laboratorio “Althènopis” o “Guerra d’infanzia e di Spagna” o “Star di casa”: quest’ultimo libro riesce adesso per i tipi della neonata Orizzonte Milton, mentre gli altri sono stati, man mano, riediti da Fazi. E non c’è giorno che l’eredità letteraria e il genio di Fabrizia non risorgano a ricordarci cosa è (davvero) scrivere: senza di lei mancherebbe il pezzo più importante della scrittura di Napoli e delle donne fra la fine del Novecento e gli anni Duemila. Da mesi, poi, ci accompagna una nuova stagione di bradisismo, un nucleo di temi, la terra che si muove, la casa che si lascia, da sempre al centro della scrittura di Ramondino, dove l’instabile genera l’inevitabile sentimento dello star di casa.
Piccolo, addolorato, meraviglioso libro, “Star di casa” racconta della Napoli bombardata del 1944 e della città terremotata del 1980, della piccola Fabrizia (classe 1936) che guarda la fontana del Nettuno di Piazza Bovio e la immagina come un condominio dove abitare con i suoi genitori mentre tutto è distrutto e pericolante e ogni bambino sta facendo il suo stesso sogno: una casa. Come mai in una città dove ci sono case su case, ammucchiate senza spazio, non si fa che sognare una casa.
Da sempre straniera in patria, cittadina della Napoli-balia, che cresce i figli e poi li deve lasciar andare, ragazzina mentre Napoli è invasa dalla furia erotica della ricostruzione postbellica e adulta durante la depressione dovuta all’instabilità del bradisisma prima e del terremoto poi, Ramondino ritrae i bombardamenti che fanno nascondere sotto terra e le scosse che fanno fuggire all’aperto; il terremoto che costringe tutti a un moto perpetuo, a camminare sempre come un rimedio omeopatico (curare il terremoto con il moto).
Il terremoto che è una “cosa”, nascosta sotto terra, cui quasi si preferirebbe l’eruzione aerea del Vesuvio, perché la “cosa” resta nascosta come un mal di vivere conradiano, un trauma freudiano.
Ramondino racconta di luoghi e generazioni: la sua, che negli anni Sessanta era troppo giovane e ingombrante, simile al Monte Nuovo sorto frettoloso e irruento in tre giorni. Intreccia il rosso pittorico della transavanguardia e quello sanguigno delle mestruazioni, il rosso ideologico della politica e quello delle case di Pompei al filo rosse delle donne (Pentesilee, amazzoni del cambiamento, donne di camorra, antenate: tutte le Arianne rimaste con un filo in mano).
E, come in “Althènopis”, narra di cucine e scale, di signore e serve, di madri e figlie e madonne. Uscito oltre un decennio dopo il suo primo, straordinario romanzo (senza “Althènopis” non c’è alcuna letteratura a seguire), “Star di casa” raccoglie frammenti avanzati sia alle pagine in luce del romanzo maggiore, sia alle note a piè di pagina, che sono una sorta di contro romanzo.
Tutto il mondo di Ramondino è convocato qui: l’infanzia, la vita in Spagna, il post-Basaglia delle donne a Trieste, l’avventura magrebina di Polisario ancora da venire, l’accidia dei salotti napoletani e la malinconia che è la culla di ogni letteratura.
Ancora oggi ci chiediamo come fare a star di casa e la risposta la scrive per noi Fabrizia, aprendo le porte a domande eterne e nuove che l’appartenere a un luogo, nonostante tutto, pone.